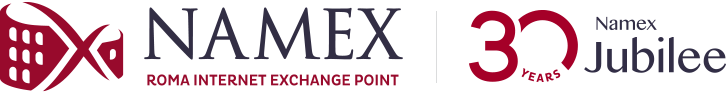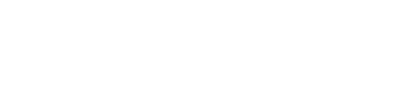— Di Innocenzo Genna, Legal specialist in EU digital policy, competition and liberalization regulations
- Lo stato del dibattito in Europa
Il dibattito europeo sul fair share si trova in una fase di quiescenza. Dopo il grande impulso profuso dal Commissario europeo Thierry Breton tra il 2022 ed il 2023, le prospettive di una possibile proposta legislativa hanno subito una brusca battuta d’arresto nell’ottobre 2023, quando i governi europei, riuniti nel Consiglio Telecom a Léon, hanno manifestato una visione in maggioranza contraria. Da quel momento l’idea di una normativa europea sul fair share è entrata in fase regressiva: per quanto ancora evocato in alcuni importanti documenti ufficiali, in particolare nel White Paper della Commissione europea sulla connettività[1] e nel Rapporto Draghi sulla competitività[2], il tema del fair share vi è apparso più come l’eco dei desideri degli stakeholder sostenitori, che come una convinta direzione istituzionale. All’interno della Commissione il fair share ha iniziato a perdere spinta propulsiva, pur rimanendo sul tavolo dell’istituzione in quanto legacy dell’agenda Breton, mentre il nuovo commissario Virkkunen non ha più caldeggiato il dibattito.
Va peraltro notato che una proposta europea sul fair share non è mai esistita. Il dibattito derivante dal movimentismo mediatico[3] di Breton non si è mai concretizzato in un documento formale o almeno preliminare – in altre parole non si è mai andati oltre le discussioni di mero principio, ad esempio con una valutazione d’impatto di un modello preciso. Ciò è stato dovuto, in parte alle differenze di vedute sull’implementazione pratica del fair share da parte delle stesse telco sostenitrici[4]; in parte all’intervento del Berec, che con un parere ben dettagliato del 2022[5] ha fatto emergere incongruenze e contraddizioni della narrativa del commissario Breton, rendendo evidente come fosse arduo realizzare una proposta concreta.
Non deve sorprendere, quindi, che i governi europei, riuniti nel Consiglio, hanno poi preso una posizione tombale sull’argomento: nelle Conclusioni della Presidenza Ungherese sul Libro Bianco[6] si legge, al §29, che qualsiasi intervento sui mercati dell’interconnessione IP dovrebbe essere giustificato da “deficencies“, quindi da un malfunzionamento del mercato dell’interconnessione IP riconosciuto sulla base di analisi economiche, e non di narrative politiche. In altre parole, il Consiglio chiude le porte al fair share inteso come una soluzione politica per riallocare, all’interno dell’ecosistema Internet, costi ed investimenti ritenuti incongrui da taluni stakeholder.
Al raffreddamento in sede europea bisogna poi aggiungere le recenti tensioni tra UE e gli USA. La nuova amministrazione Trump ha infatti indicato i meccanismi di network fee (il termine americano per “fair share”) come una potenziale barriera al commercio USA, in quanto tale suscettibile di retaliation attraverso dei dazi[7]. Secondo la Casa Bianca, il nuovo trattato commerciale tra UE ed US, annunciato il 28 luglio 2025, comporterà l’impegno per cui “the European Union confirms that it will not adopt or maintain network usage fees“[8].
Con questo non bisogna concludere che il dibattito sul fair share sia definitivamente tramontato all’interno della UE. Trattandosi di un dibattito ciclico – ed infatti siamo già al terzo round, dopo le discussioni già avute in sede OCSE negli anni ’90 e all’ITU nel 2012 – niente impedisce che proposte pertinenti tendano a ripresentarsi in un futuro prossimo, quando le condizioni politiche lo permetteranno.
In proposito, è bene ricordare che la Commissione europea presenterà, entro la fine del 2025, una proposta di riforma del quadro regolamentare europeo delle comunicazioni elettroniche denominato “Digital Network Act” (“DNA”). Al momento non sappiamo se un meccanismo di fair share ne farà parte. Nel prospetto di consultazione europea per il DNA[9] è menzionata una frase alquanto vaga e sibillina sul fatto che il DNA potrebbe conferire al BEREC o alle autorità nazionali la competenza ad intervenire per facilitare una sorta di “cooperazione” tra i vari attori del “broader connectivity ecosystem“. Non è però chiaro cosa la Commissione abbia ora in mente: introducendo un termine nuovo, quello della “cooperazione”, ed abbandonando i modelli classici su cui si era sviluppato il dibattito sul fair share, che si basavano su dei pagamenti regolamentati legati all’interconnessione IP oppure al servizio universale, la Commissione sembra orientarsi verso una nuova via, di cui però non si conoscono i termini. E’ inoltre possibile che il tema sia destinato a ad essere scambiato, quando si arriverà al momento delle negoziazioni nel processo di co-legislazione, con altri argomenti per i quali vi siano invece maggiori speranze o ambizioni di accordo.
- Il recente caso italiano: AGCOM e le CDN
La ciclicità latente del fair share fa sì che gli stakeholders coninuino a tenerne vivo il dibattito, pur in assenza di una determinata agenda legislativa sul punto. Non sorprende, quindi, che siano sorte forti discussioni in Italia quando, recentemente, il regolatore AGCOM ha lanciato una consultazione pubblica[10] sul trattamento regolamentare delle CDN, anche al fine di verificarne l’assoggettabilità alla disciplina delle autorizzazioni. Alcuni hanno temuto, altri sperato, che l’iniziativa costituisse l’anticamera di un nuovo quadro legislativo che, equiparando le CDN a delle reti pubbliche, di fatto assoggettasse tali infrastrutture ad un obbligo di contributo a favore delle telco (a seguito di controversie di interconnessione devolute alla stessa AGCOM).
A prescindere da quali possano essere i piani di AGCOM, è bene rilevare che il regolatore italiano sembra essersi mosso nell’ambito della disciplina vigente, cioè dell’attuale Codice europeo delle comunicazioni elettroniche[11], e senza oltrepassarne i limiti. Pertanto, se fair share dovesse essere, lo sarebbe perché già previsto dal Codice europeo, non per una novella legislativa di AGCOM.
Tuttavia, è quanto mai dubbio se il Codice europeo, nell’attuale forma, possa consentire l’introduzione di un fair share nazionale attraverso il meccanismo delle controversie di interconnessione, come paventano (o sperano) alcuni commentatori della consultazione. In effetti, la disciplina europea sull’interconnessione, consolidata da oltre 20 anni e che attualmente trova espressione nell’art. 61 del Codice europeo, ha lo scopo di facilitare l’interconnessione tra reti e quindi la connettività end-to-end, ma non di compensare i potenziali squilibri di investimento o profittabilità all’interno dell’ecosistema di Internet. Le autorità di regolazione intervengono quindi per facilitare l’interconnessione e garantirla quando questa venga rifiutata in modo ingiustificato, non per altri scopi. L’intervento regolamentare può essere invocato anche per stabilire i costi di interconnessione, ma si tratta di un evento raro, perché la stragrande maggioranza delle transazioni sono settlement-free, in quanto l’interesse ad una connettività efficiente e di alta qualità prevale sull’eventuale recupero dei costi di interconnessione (il cui ammontare è comunque moderato e peraltro plafonato dal mercato del IP transit). Nel mercato si ravvisano anche situazioni di paid peering; quando però le tariffe sono troppo alte, soprattutto da parte di ISP dominante, tali fattispecie possono in verità celare dei veri e propri rifiuti a contrarre, e quindi dei potenziali abusi antitrust, da cui i rari casi di controversia[12].
Ad ogni modo, in caso di disaccordo sui costi di interconnessione non vi è una chiara base giuridica nel Codice europeo per poter giustificare la corresponsione di una somma che vada oltre i meri costi di interconnessione, ad esempio nella forma di un contributo agli investimenti in infrastrutture da parte di un’azienda all’altra. La narrativa del fair share è estranea allo scopo dell’interconnessione come la conosciamo, anzi appare antitetica, poichè la litigiosità che scaturirebbe da un modello di fair share basato sulle controversie di interconnessione porterebbe pregiudizio alla rapida ed efficiente connettività end-to-end che invece la disciplina europea dell’interconnessione vorrebbe garantire. In altre parole, a prescindere dall’opinione che si possa avere sul fair share[13], per poterlo attuare oggigiorno con una controversia di interconnessione occorrerebbe, in via preliminare, una modifica del Codice europeo che modificasse scopo e finalità dell’interconnessione classica.
Discorso diverso invece può essere fatto per i casi in cui un content provider possa essere chiamato a compiere una serie di investimenti, anche in cooperazione con le reti di telecomunicazioni con cui si interconnette, per garantire stabilità e qualità del servizio agli utenti finali, come accaduto in Italia con il caso DAZN. Non si tratterebbe di un litigio di interconnessione o di un tema di fair share, bensì della semplice applicazione di obblighi che incombono ad un operatore di rete pubblica per la trasmissione dei propri contenuti[14].
- La giurisprudenza in tema di interconnessione, ed il caso Deutsche Telekom/Meta
Il quadro sopra descritto appare confermato dalla (rara) giurisprudenza in tema di controversie di interconnessione, in genere riguardante casi di rifiuto di interconnessione o di costi manifestamente abusivi da parte di alcune telco dominanti (in Germania, Olanda, Francia e Svizzera).
Ciò vale anche per il recente caso Deutsche Telekom / Meta, invocato normalmente a sproposito nei dibattiti politici o lobbistici sul fair share. Si è trattata in verità di una mera controversia civilistica, non regolamentare. Deutsche Telekom e Meta sono finite avanti il giudice di Colonia perché il primo ha unilateralmente aumentato le tariffe di peering al secondo, il quale, invece che disconnettersi ed optare per un’alternativa (cioè consegnare in transito il traffico diretto a Deutsche Telekom) ha continuato ad usufruire dei servizi dell’ISP tedesco, ritenendo, in attesa dell’esito della controversia, di poter continuare a basarsi sulle vecchie tariffe di peering. Il giudice ha dato torto a Meta in virtù di semplici motivazioni civilistiche, non certo per un principio di fair share. Per dirla in breve: “Se non sei d’accordo con un nuovo prezzo te ne devi andare, non puoi continuare ad usufruire dei servizi“. Meta però ha voluto rischiare ed è rimasta “interconnessa” a Deutsche Telekom, probabilmente perchè ha fatto affidamento sulla prassi generale del mercato del peering improntata al free-settlement (che però è una prassi, non una regola giuridica) e sul fatto che certi comportamenti di Deutsche Telekom sono potenzialmente censurabili in quanto essa impresa dominante sull’accesso. Quest’ultimo punto è stato verosimilmente rigettato dal giudice tedesco perchè Meta poteva realisticamente instradare il traffico in modo alternativo, cioè comprando un servizio di IP transit (cosa che Meta infatti alla fine ha fatto[15]). Tuttavia, la possibilità che un ISP dominante possa commettere degli abusi attraverso una politica di peering restrittiva o poco chiara resta attuale ed era stata già evocata dall’antitrust francese in uno dei primi leading case in questa materia, il caso Cogent/Orange del 2012[16].
In conclusione, il caso Deutsche Telekom / Meta non è stato un contenzioso regolamentare ai fini del riconoscimento del fair share, bensì una semplice controversia civilistica e contrattuale che verteva sul pagamento di servizi già erogati.
- Conclusioni
Le attuali norme europee sull’interconnessione non consentono di obbligare un soggetto, sia esso fornitore di contenuti, oppure operatore di comunicazioni elettroniche, a ripagare gli investimenti in infrastrutture dell’altro operatore con cui si fa peering, al di là dei meri costi di interconnessione. Le parti sono libere di stabilire le tariffe ed eventualmente di non interconnettersi affatto, se esistono delle alternative per instradare il traffico, ed è questo il motivo per cui i contenziosi sono molto rari.
Per andare oltre questo quadro giuridico servirebbe una esplicita revisione delle norme europee sull’interconnessione, così ipotizzando una novella che specifichi, come scopo dell’interconnessione, il ristoro degli investimenti da parte di una parte dei confronti dell’altra, e non la semplice attuazione dell’interconnessione tra reti. Si tratterebbe di una ipotesi delicata perché introdurrebbe nel mercato del peering una variabile di litigiosità che ne impatterebbe il funzionamento in modo significativo. Inoltre, il principio del ristoro degli investimenti – assolutamente soggettivo e suscettibile di applicazioni arbitrarie – potrebbe in futuro rivelarsi un boomerang per le telco qualora certi OTT volessero far valere e mettere sul piatto i propri investimenti in cloud, AI, software e cavi sottomarini.
Ne consegue che un fair share europeo nel campo dell’interconnessione si attuerebbe in una vera e propria terra incognita e quindi andrebbe valutato con grande attenzione, come peraltro raccomandato dal Consiglio nelle richiamate Conclusioni della Presidenza Ungherese che appunto “frenano” sul fair share.
Restano aperte le possibilità di imporre il fair share per altra via, ad esempio con una retaliation nell’ambito della guerra sui dazi americani oppure attraverso l’istituzione di un fondo ad hoc sulla falsariga di quello per il servizio universale. Ma si tratterebbe anche qui di novelle assolutamente uniche e dagli impatti al momento imprevedibili.
Non si può peraltro escludere che in futuro i contenziosi aumentino per effetto della crescente concentrazione del mercato, sia dal lato telecom che Internet. Ciò potrebbe riguardare gli ISP dominanti e che applicano politiche di peering sempre più restrittive, contro i quali giudici o autorità antitrust potrebbero ipotizzare un abuso di posizione dominante in relazione al monopolio di terminazione; ma anche nei confronti di un OTT dominante (e magari designato come gatekeeper ai sensi del DMA) a cui potrebbe essere contestata, in quanto abusiva, l’imposizione di un peering gratuito a fronte di oggettivi costi di interconnessione che le controparti devono sopportare.
[1] EUROPEAN COMMISSION, White Paper – How to master Europe’s digital infrastructure needs?, 21 febbraio 2024.
[2] MARIO DRAGHI, The future of European competitiveness, settembre 2024.
[3] LES ECHOS, Bruxelles veut faire payer les réseaux télécoms aux Gafam, 4 maggio 2022.
[4] Vi sono importanti divergenze, inter alia, sul modello da attuare (se debba trattarsi di una tariffa di interconnessione, oppure di un contributo ad un fondo specializzato), sull’individuazione di soggetti obbligati e beneficiari, sugli eventuali meccanismi di arbitraggio, sulla misurazione del traffico.
[5] BEREC, Preliminary assessment of the underlying assumptions of payments from large CAPs to ISPs, 7 ottobre 2022.
[6] CONSIGLIO, Council conclusions on the White Paper “How to master Europe’s digital infrastructure needs?”, 6 dicembre 2024.
[7] WHITE HOUSE, Defending American Companies and Innovators From Overseas Extortion and Unfair Fines and Penalties, 21 febbraio 2025.
[8] WHITE HOUSE, The United States and European Union Reach Massive Trade Deal, 28 luglio 2025
[9] Call for evidence for an evaluation and impact assessment run in parallel, 6 giugno 2025.
[10] AGCOM, Delibera 55/25/CONS Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica per la ricognizione delle condizioni di applicabilità del regime di autorizzazione generale previsto dal codice alle Content Delivery Network (CDN), 6 marzo 2025
[11] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche
[12] Per una disamina dei maggiori casi di controversia di peering: RADIOBRUXELLESLIBERA, The Fair Share repository, aggiornamento 2025.
[13] La mia opinione è stata resa, nella fase iniziale del dibattito, in RADIOBRUXELLESLIBERA, Fair share: the definitive guide, gennaio 2023.
[14] In seguito alla delibera n. 206/21/CONS, DAZN ha conseguito l’autorizzazione generale, ai sensi dell’art. 11 del Codice italiano, per l’installazione e la fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica e per la trasmissione dati a commutazione di pacchetto
[15] META, Why We’re Having to End Our Direct Peering Relationship With Deutsche Telekom, 25 settembre 2024
[16] BUCKLEY, Cogent and Orange France fight over interconnection issues, 2011.